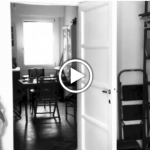A partire dal duemila, in seguito alla segnalazione e denuncia di aggressioni sessiste da parte di attiviste di movimento, a Barcellona si è sviluppato un intenso dibattito sulla violenza di genere interna al movimento stesso, dibattito che ha coinvolto diverse realtà, non solo catalane, ma anche italiane, quali collettivi femministi, singolarità, gruppi di discussione autorganizzati, misti e non. La lunga serie di dibattiti è culminata nella pubblicazione, a cura del collettivo editoriale La Haine, di un dossier intitolato Tijeras para todas – textos sobre violencia de genero en movimientos sociales / Forbici per tutte – testi sulla violenza di genere nei movimenti sociali, una cassetta degli attrezzi, da tenere a portata di mano, per riconoscere, denunciare e combattere i conflitti di genere che ancora attraversano i movimenti, nella convinzione che, poiché non esiste una gerarchia delle lotte, secondo la quale alcune sarebbero più importanti di altre, l’antisessismo non può essere accantonato temporaneamente per far posto ad altre priorità. In fin dei conti, quando si tratta di sessismo, il confine tra il dentro e il fuori il movimento è fittizio e la violenza è sempre la stessa, poiché le dinamiche non differiscono da quelle della società in generale. Il dossier si presenta come un invito all’azione ed è diviso in tre sezioni: il contesto, ossia la violenza machista nelle aree di movimento, da cui proviene chi ha partecipato alla realizzazione di Tijeras para todas; testi scritti come risposta ad aggressioni maschiliste ed infine proposte di azione femminista diretta.
Di fronte alle incessanti trasformazioni delle nostre società postindustriali e globalizzate, le strategie di movimento, oramai in crisi, anche perché incapaci di andare oltre la dinamica azione-reazione, attacco-risposta, hanno dismesso l’impegno sovversivo e hanno ripiegato su una “moralità antagonista” tutta protesa a distinguere ciò che è bene da ciò che è male, con conseguente espulsione delle soggettività irriducibili ad ogni manicheismo. In questo quadro decisamente reazionario, dal momento che elimina ogni voce di dissenso e reprime ogni esigenza di trasformazione radicale dell’esistente, si ripropone un immaginario vecchio e stantio, che si fonda su dicotomie classiche, prima fra tutte quella maschile/femminile. Così, quando nel centro sociale c’è un collettivo di donne, tutto ciò che ha a che vedere con il sessismo e la violenza di genere ricade su di loro. Il femminismo è ritenuto questione di donne, agli altri non interessa, se non per la patina di progressismo che conferisce al centro sociale medesimo.
Per converso, l’immaginario collettivo di movimento è dominato in larga misura dal mito del buon militante, il leader le cui virtù sono esasperate a tal punto da assumere tratti caricaturali in alcune figure prototipo: giovane uomo bianco con cappuccio nero e propensione alla violenza, le sue caratteristiche sono la forza, il coraggio, la decisionalità, la capacità di osare e, soprattutto, di tenere nascoste le sue contraddizioni. Da un altro lato, incontriamo il modello dell’intellettuale, con buona preparazione teorica (o almeno attitudine a dimostrarla), forte capacità di persuasione, doti organizzative e direttive e tendenza alla leadership. Entrambe le varianti mantengono i tratti della mascolinità tradizionale, ma mentre il primo è più prossimo all’idea normativa di mascolinità delle classi basse, il secondo rappresenta la variante alto-borghese.
Sia il modello dell’eroe incappucciato che quello dell’intellettuale, entrambi normati e normativi, possono dar luogo a maltrattamenti, sia fisici che psicologici: bavosità varie ed eventuali, percosse, tentativi di ottenere rapporti sessuali forzatamente sono maltrattamenti fisici evidenti, ma sono forme di violenza invisibilizzata, e non per questo meno grave, anche la creazione di rapporti di dipendenza e di subalternità fra sessi, in cui una donna viene indotta a credere che, senza il consenso maschile, lei da sola non vale niente. Così, criticare quello che comunemente viene ritenuto “un buon compagno”, ha come contropartita il ricevere l’accusa di fare il gioco del sistema e di non capire che ci sono questioni più importanti da affrontare. Di conseguenza, qualsiasi critica interna viene trasformata in un attacco “alla causa” ed il gruppo, ricorrendo a strategie di corporativismo maschile, si chiude in una difesa identitaria del “noi”, lanciando un appello militaresco all’unione ed all’isolamento dell’eretica al quale, non di rado, rispondono anche le cosiddette compagne. E ciò risulta estremamente facile quando la ricerca del consenso assume una priorità assoluta ed autoreferenziale in un gruppo dove più della metà non ha un pensiero critico autonomo, ma si accontenta di discorsi preconfezionati analoghi a quelli di qualsiasi telegiornale e per di più pretende che tali discorsi vengano posti sullo stesso piano di opinioni maturate a seguito di un lungo lavoro, tentando così di abbassare ai minimi termini il livello della discussione.
Davanti al rischio di un conflitto interno, si rinforzano i ruoli di genere prestabiliti, che per le donne corrispondono al mediare, pacificare, comprendere e, dunque, al prendersi cura del gruppo e della sua coesione. Così, paradossalmente, anche le “compagne” finiscono per mettere al primo posto la difesa del gruppo identitario insieme alla ricerca di un consenso mediocre, nell’illusione che l’aggressione alla dissidente non sia un problema di tutte. La retorica dello spazio liberato è funzionale a questa strategia e finisce per mistificare la realtà, come se la lotta contro il sistema fosse più importante della lotta contro tutto ciò che di questo abbiamo interiorizzato. Nessun@ di noi può dirsi liber@ fino in fondo, perché tutt@ viviamo in un sistema di cui assorbiamo le norme fin dalla nascita. Nessuno spazio okkupato, o liberato che dir si voglia, è immune dal riprodurre le stesse dinamiche che regolano i rapporti sociali strutturati sul binarismo di genere, con conseguenti derive sessiste. Chiunque attraversi la realtà dei centri sociali, senza lasciarsi fagocitare e rinchiudere dai loro recinti, noterà facilmente come i ruoli di genere, nella maggior parte dei casi, vengono riprodotti fedelmente, rinforzati e dunque naturalizzati. Mentre infatti gli uomini organizzano l’agenda politica, stabiliscono la programmazione del centro sociale, arringano le “masse” durante le iniziative pubbliche, le donne cucinano, passano la serata a servire al bar e poi puliscono tutto. Con questa divisione di compiti, i ruoli di genere non solo non vengono messi in discussione, ma sono rinforzati e naturalizzati, perché viene assunto come dato naturale il fatto che un’assemblea sia diretta al maschile, mentre le donne preparano i pasti per tutt@, servono al bar e provvedono a mantenere tutto in ordine, assumendosi la cura del centro sociale e di chi lo attraversa.
In tale contesto normato, chi fa eccezione va ricondott@ in qualche modo ad un modello per così dire familiare e a sua volta stereotipato. Così, al mito dell’eroe fa da contraltare quello dell’eroina, colei che non si piega e non si assoggetta, una donna liberata che in qualche misura deve corrispondere al macho bianco moderno: indipendente, forte, attiva, sicura e anche lei esente dalle contraddizioni. E’ questa un’altra mistificazione della realtà, oltre che un prodotto del patriarcato, perché essere una militante femminista non implica né l’essere immune da contraddizioni, né il poter fare a meno delle altre (e degli altri). Nessuna di noi è completamente autonoma perché tutt@ cresciamo in un sistema etero-patriarcale che si fonda su legami di dipendenza, né qualsiasi problema è risolvibile individualmente. Rompere l’immagine di donna forte e dura, vivere con le proprie molteplici sfaccettature, performare la propria vita in maniera diversa sulla base delle circostanze, manifestare il malessere e chiedere aiuto, sono pratiche sovversive che disarticolano l’etero-patriarcato. Le barriere da abbattere sono numerose e resistenti ed il lavoro si fa più arduo quando si continua con incertezza e titubanza a cercare delle possibili soluzioni, affibbiando alla singola la responsabilità ultima di una ferma risposta ad episodi di autoritarismo e sessismo, se non di violenza vera e propria, fisica e/o psicologica.
La violenza strutturale è un meccanismo di controllo sulle donne non solo quando si manifesta in forma estrema ed evidente, ma anche in quanto si dà come relazione normalizzata e naturalizzata che si può esercitare senza bisogno di giustificazione. Dunque, oltre a saper riconoscere la violenza di genere come fatto strutturale, è indispensabile creare le condizioni necessarie per evitarla e assumerci la responsabilità di ciò che ci accade intorno. Nella maggior parte delle situazioni non risulterà chiaro come reagire, però si può far in modo di aver chiaro almeno il fatto che bisogna parlarne, discuterne e non silenziare le questioni, perché il silenzio significa accettare la situazione, non dare visibilità ai problemi e impedire che si trovino soluzioni, tanto collettive, quanto individuali, nel tentativo di “evitare lo scandalo”. Invece, che si abbia il coraggio di dare scandalo impedendo di normalizzare la musica sessista nei concerti, gli slogan sessisti alle manifestazioni, le posizioni di superiorità nelle assemblee e nelle relazioni, i ruoli divisi per genere. Smettiamola con la dicotomia buon@/cattiv@ che abbiamo imparato nelle favole della nosta infanzia. Gli eroi non esistono. Piuttosto, impariamo a metterci in discussione in qualsiasi momento, rifiutamoci di simulare tranquillità e di accettare situazioni che ci infastidiscono e, soprattutto, prestiamo ascolto a chi ha il coraggio di farlo. Le soluzioni perfette non esistono, però esiste la possibilità di cambiare ciò che non piace. Non siamo migliori, però possiamo ambire a vivere meglio gli spazi che attraversiamo.
Di seguito, il manifesto distribuito nei centri sociali ed in ambienti politici di movimento dall’ Assemblea di genere di Barcellona, 2004.
Aggressione è quando mi sento aggredita
Se mi sento aggredit@ reagisco come mi pare. In una situazione di aggressione, quello che voglio reprimere è l’aggressione stessa, non la reazione a questa.
Se mi sento aggredit@ non voglio sentirmi sol@ per il fatto che è la prima volta che sto qui, perché non conosco nessun@ o poca gente, per la paura che non mi diano appoggio o per qualsiasi altro motivo.
E collettivamente?
Non vogliamo essere il/la macho, né il protettore/la protettrice di nessun@, però nemmeno vogliamo usare questo come scusa per non fare niente.
Non vogliamo guardare dall’altro lato quando siamo presenti ad un’aggressione. Un’aggressione non si verifica solo tra chi aggredisce e chi è aggredit@. Anche noi siamo qui! Vogliamo starci bene e non vogliamo passarci sopra!
Gli spazi “liberati” non sono esenti da aggressioni.